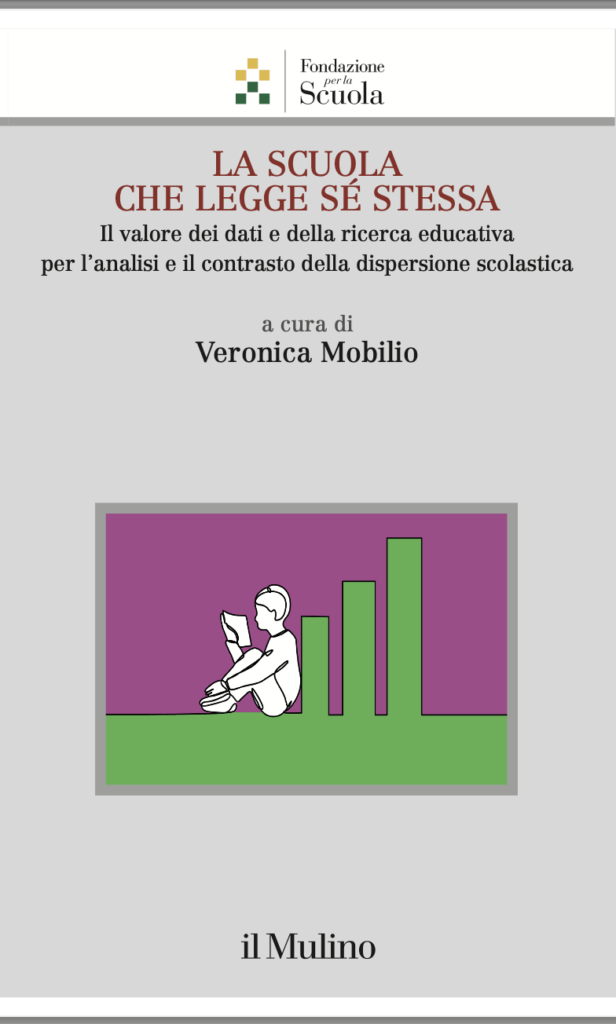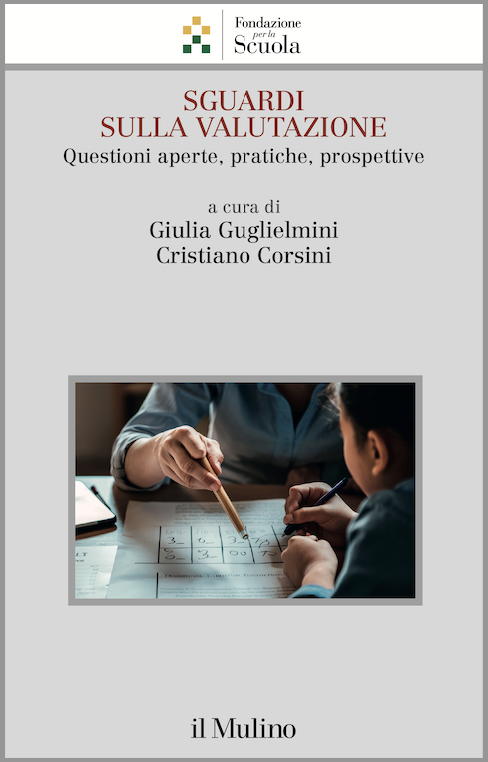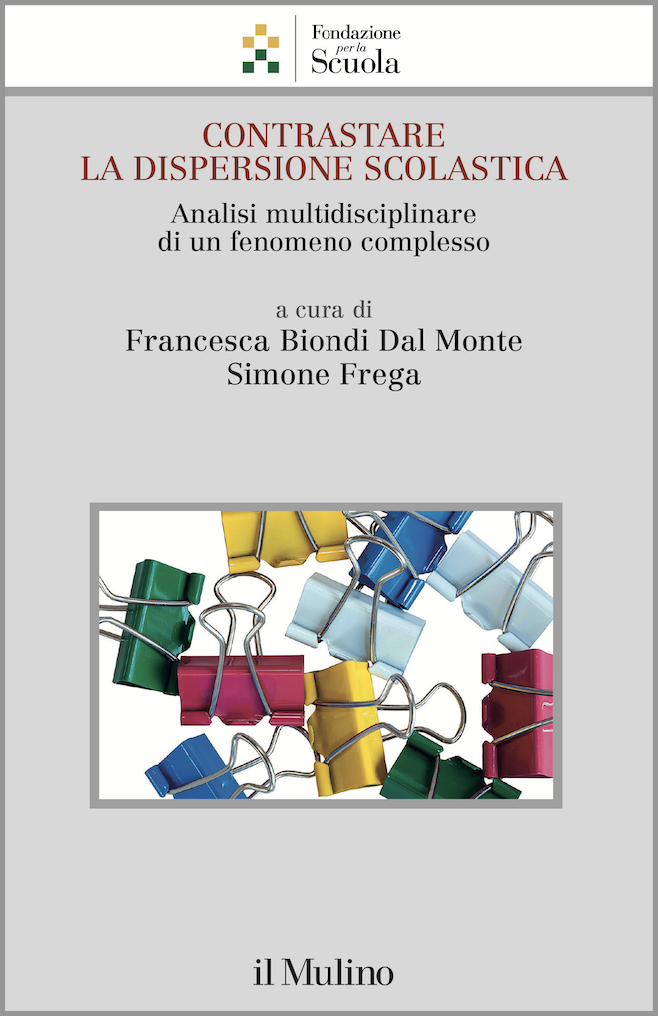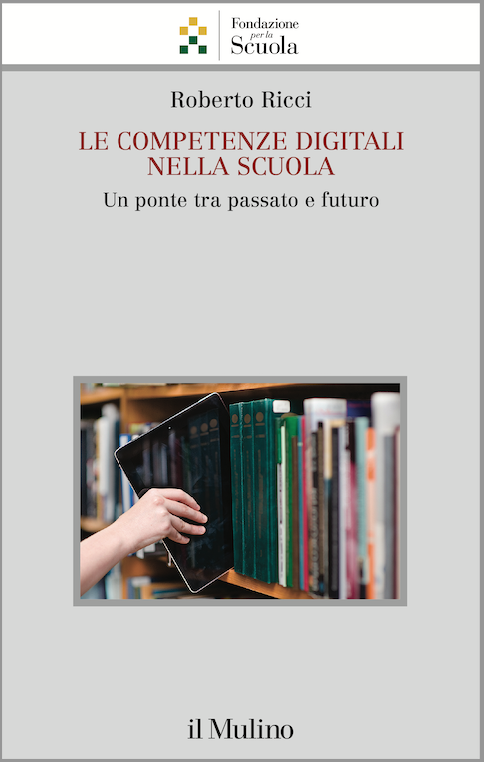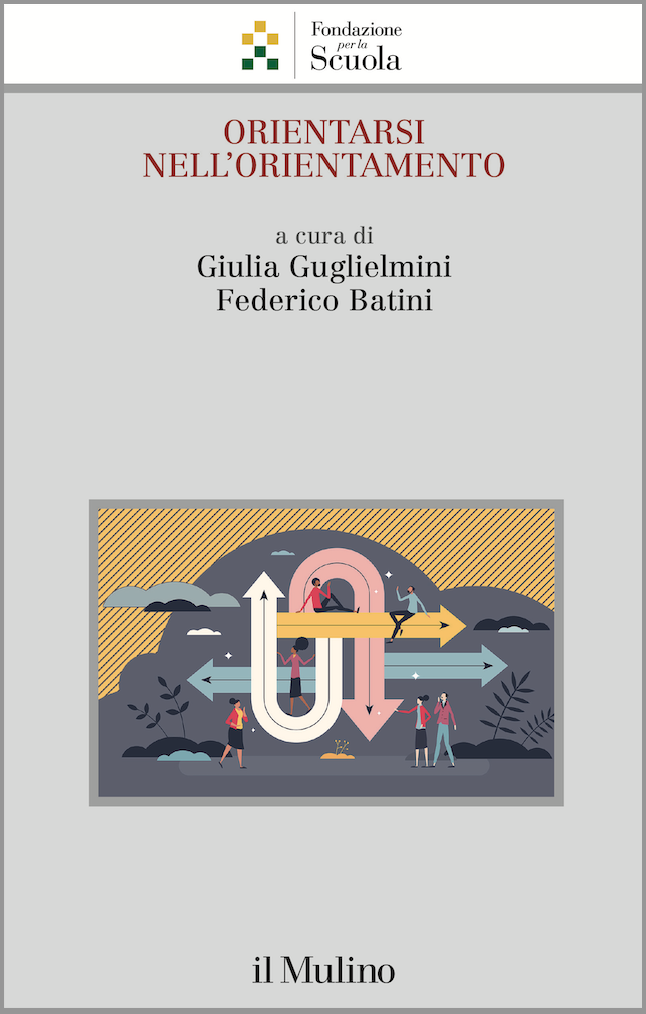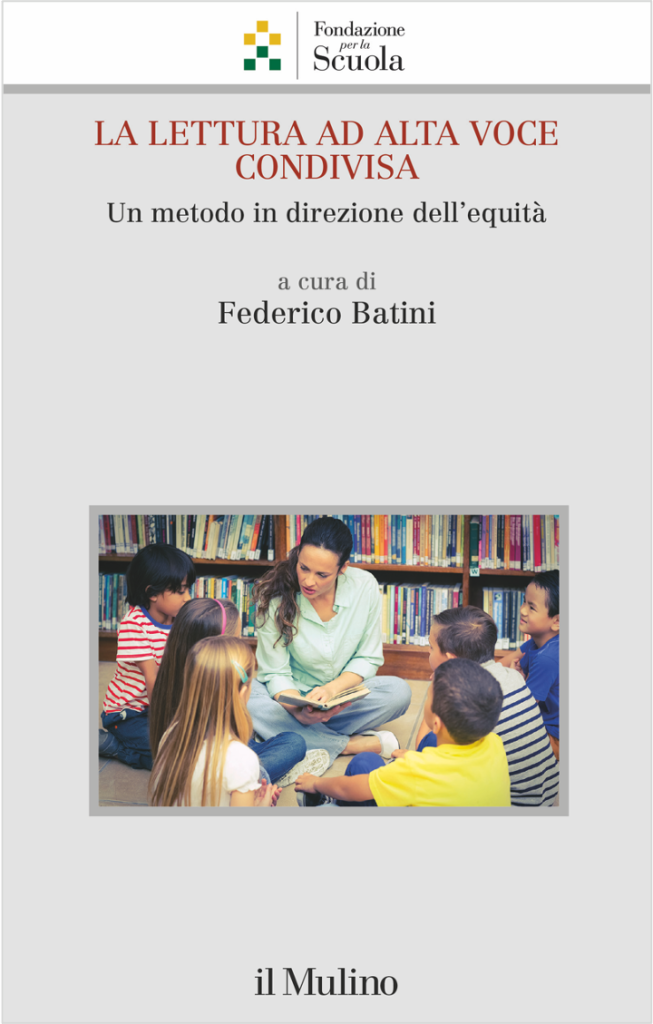Pubblichiamo da tempo volumi che raccolgono i risultati di studi, analisi e ricerche in campo educativo. Attraverso la collana edita da “Il Mulino”, approfondiamo i passaggi più significativi del dibattito sulla scuola, seguendo i cambiamenti e l’evoluzione del mondo dell’istruzione e dando voce a risultati ed evidenze di studi e ricerche realizzate da noi o provenienti da realtà accreditate a livello italiano e internazionale.
ULTIMA PUBBLICAZIONE
DELLA COLLANA EDITORIALE “IL MULINO”
La scuola che legge sé stessa
A cura di Veronica Mobilio
Filtra per: